Gli Déi degli altri: una lezione romana per l’Isis (e per noi)

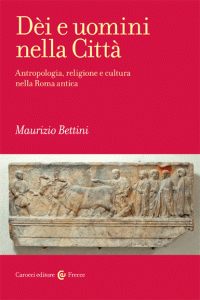 Roma, 18 nov – Che cosa succede quando un Dio incontra un altro Dio? Meglio: quale dispositivo culturale si mette in moto quando un’umanità che si è affidata a una divinità incontra un’umanità diversa che porta nel cuore una differente divinità?
Roma, 18 nov – Che cosa succede quando un Dio incontra un altro Dio? Meglio: quale dispositivo culturale si mette in moto quando un’umanità che si è affidata a una divinità incontra un’umanità diversa che porta nel cuore una differente divinità?
Una delle risposte possibili – la più comune oggi giorno, a ogni latitudine, anche se non sempre con questa virulenza – l’abbiamo vista quando l’Isis è arrivata a Palmira, dove di Dèi ne sono transitati parecchi, in effetti. In quel caso, il Dio vero scaccia il Dio falso, anche quando di questo non sopravvive che l’ombra sulle antiche colonne. Cadono così templi pagani, chiese cristiane, ma anche moschee.
La risposta è quella dettata dall’eresia wahabita e che anche nella stessa Arabia Saudita, in due secoli, ha portato alla distruzione di centinaia di cimiteri, sepolcri, moschee, oratori e siti religiosi. Già ai suoi tempi, del resto, Libanio, il maestro di retorica devoto a Giuliano Augusto, lanciava strali contro gli “uomini vestiti di nero, che mangiano più degli elefanti” e che “si scagliano contro i templi portando legna, pietre e ferro. E quelli che non ne hanno usano mani e piedi. Poi i tetti vengono buttati giù, i muri sfondati, le statue abbattute, gli altari rovesciati, i sacerdoti indotti al silenzio o costretti a morire”. Sembra la descrizione dell’ingresso degli sgherri del Califfato in qualche museo della Mezzaluna fertile, ma siamo in un’altra epoca, in un altro luogo e abbiamo a che fare con altri fanatismi.
fertile, ma siamo in un’altra epoca, in un altro luogo e abbiamo a che fare con altri fanatismi.
C’è però un altro modo di rapportarsi alla pluralità delle teofanie. I Romani, per esempio, si davano all’interpretatio. Ce lo ricorda Maurizio Bettini, classicista e docente di Filologia classica all’Università di Siena, fondatore del Centro di antropologia del mondo antico. Guardare a Roma con gli occhi dell’antropologo: osservare ciò che siamo stati, ciò che forse è ancora in una parte di noi, con gli occhi degli studiosi che per definizione studiano l’altro: anche questo è significativo, a suo modo. Di Bettini è appena uscito Dèi e uomini nella Città (Carocci, pp. 213, € 19,00), che presenta sei saggi su alcuni dei più intriganti misteri della società romana.
L’antropologo, spiega l’autore, comincia sempre col chiedersi perché gli altri facciano qualcosa che ai nostri occhi appare bizzarro e inquietante. Poi passa a chiedersi: “E perché noi non lo facciamo?”. Il che, nel caso dei Romani, equivale a chiedersi: “Perché noi non lo facciamo più?”. È proprio il caso dell’interpretatio e di ciò che, all’inverso, accade oggi quando incontriamo l’altro e crediamo di doverlo esorcizzare annullando noi o sterminando lui.
Tacito racconta di due divinità appartenenti al popolo dei Naharvali, gli Alci. L’autore della Germania spiega che, essendo le due divinità due giovani fratelli, nell’interpretatio romana gli Alci vengono chiamati Castore e Polluce. Su questa riga, la critica moderna ha costruito un dibattito infinito, facendo dell’interpretatio la categoria generale con cui i Romani “traducevano” le divinità altrui nel proprio linguaggio, proprio come se esistesse un Google Translate dei numi.
Bettini dimostra invece quanto congetturale e sperimentale sia sempre, per i Romani, l’individuazione di un Dio e la spiegazione della sua funzione in un linguaggio comprensibile agli abitanti dell’Urbe. Quanto sforzo di comprensione vi sia, quanta attenzione alla vis, alla “forza”, alla “funzione” in atto quando si incontra un Dio sconosciuto.
Ma se è possibile identificare un Dio “nostro” con uno “straniero”, allora gli Dei sono ovunque gli stessi? Ai Romani, posta in questi termini, la questione sarebbe interessata poco: il “relativismo” romano è sempre etnocentrico, se ne frega di questioni poste a partire da “nessun luogo”. Né, per conquistare altri popoli, avevano bisogno della legittimazione morale derivante dall’essere portatori di quei valori che sarebbero “comuni a tutti”.
“Chi dice umanità cerca di ingannarti”, ammoniva Pierre-Joseph Proudhon. I Romani, infatti, non parlavano di umanità, ma di humanitas, che è “un merito piuttosto che un tratto universale”, come scrive Paul Veyne.
Ciò non toglie che il loro modo di rapportarsi all’altro da sé debba fare ancora oggi scuola: sia per la plasticità, la dinamicità, lo sforzo di comprensione della diversità che è oggi sapienza dimenticata e calpestata nel Vicino Oriente, sia per l’inderogabile centratura in se stessi che l’accompagnava e che non si tramutò mai, a Roma, in pensiero debole, tanto meno in quell’odio di sé che è oggi religione civile in Occidente.
Adriano Scianca
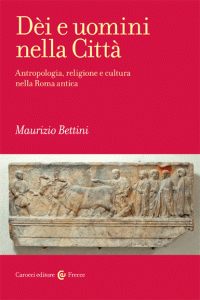 Roma, 18 nov – Che cosa succede quando un Dio incontra un altro Dio? Meglio: quale dispositivo culturale si mette in moto quando un’umanità che si è affidata a una divinità incontra un’umanità diversa che porta nel cuore una differente divinità?
Roma, 18 nov – Che cosa succede quando un Dio incontra un altro Dio? Meglio: quale dispositivo culturale si mette in moto quando un’umanità che si è affidata a una divinità incontra un’umanità diversa che porta nel cuore una differente divinità?Una delle risposte possibili – la più comune oggi giorno, a ogni latitudine, anche se non sempre con questa virulenza – l’abbiamo vista quando l’Isis è arrivata a Palmira, dove di Dèi ne sono transitati parecchi, in effetti. In quel caso, il Dio vero scaccia il Dio falso, anche quando di questo non sopravvive che l’ombra sulle antiche colonne. Cadono così templi pagani, chiese cristiane, ma anche moschee.
La risposta è quella dettata dall’eresia wahabita e che anche nella stessa Arabia Saudita, in due secoli, ha portato alla distruzione di centinaia di cimiteri, sepolcri, moschee, oratori e siti religiosi. Già ai suoi tempi, del resto, Libanio, il maestro di retorica devoto a Giuliano Augusto, lanciava strali contro gli “uomini vestiti di nero, che mangiano più degli elefanti” e che “si scagliano contro i templi portando legna, pietre e ferro. E quelli che non ne hanno usano mani e piedi. Poi i tetti vengono buttati giù, i muri sfondati, le statue abbattute, gli altari rovesciati, i sacerdoti indotti al silenzio o costretti a morire”. Sembra la descrizione dell’ingresso degli sgherri del Califfato in qualche museo della Mezzaluna
 fertile, ma siamo in un’altra epoca, in un altro luogo e abbiamo a che fare con altri fanatismi.
fertile, ma siamo in un’altra epoca, in un altro luogo e abbiamo a che fare con altri fanatismi.L’antropologo, spiega l’autore, comincia sempre col chiedersi perché gli altri facciano qualcosa che ai nostri occhi appare bizzarro e inquietante. Poi passa a chiedersi: “E perché noi non lo facciamo?”. Il che, nel caso dei Romani, equivale a chiedersi: “Perché noi non lo facciamo più?”. È proprio il caso dell’interpretatio e di ciò che, all’inverso, accade oggi quando incontriamo l’altro e crediamo di doverlo esorcizzare annullando noi o sterminando lui.
Tacito racconta di due divinità appartenenti al popolo dei Naharvali, gli Alci. L’autore della Germania spiega che, essendo le due divinità due giovani fratelli, nell’interpretatio romana gli Alci vengono chiamati Castore e Polluce. Su questa riga, la critica moderna ha costruito un dibattito infinito, facendo dell’interpretatio la categoria generale con cui i Romani “traducevano” le divinità altrui nel proprio linguaggio, proprio come se esistesse un Google Translate dei numi.
Bettini dimostra invece quanto congetturale e sperimentale sia sempre, per i Romani, l’individuazione di un Dio e la spiegazione della sua funzione in un linguaggio comprensibile agli abitanti dell’Urbe. Quanto sforzo di comprensione vi sia, quanta attenzione alla vis, alla “forza”, alla “funzione” in atto quando si incontra un Dio sconosciuto.
Ma se è possibile identificare un Dio “nostro” con uno “straniero”, allora gli Dei sono ovunque gli stessi? Ai Romani, posta in questi termini, la questione sarebbe interessata poco: il “relativismo” romano è sempre etnocentrico, se ne frega di questioni poste a partire da “nessun luogo”. Né, per conquistare altri popoli, avevano bisogno della legittimazione morale derivante dall’essere portatori di quei valori che sarebbero “comuni a tutti”.
“Chi dice umanità cerca di ingannarti”, ammoniva Pierre-Joseph Proudhon. I Romani, infatti, non parlavano di umanità, ma di humanitas, che è “un merito piuttosto che un tratto universale”, come scrive Paul Veyne.
Ciò non toglie che il loro modo di rapportarsi all’altro da sé debba fare ancora oggi scuola: sia per la plasticità, la dinamicità, lo sforzo di comprensione della diversità che è oggi sapienza dimenticata e calpestata nel Vicino Oriente, sia per l’inderogabile centratura in se stessi che l’accompagnava e che non si tramutò mai, a Roma, in pensiero debole, tanto meno in quell’odio di sé che è oggi religione civile in Occidente.
Adriano Scianca
Nessun commento:
Posta un commento